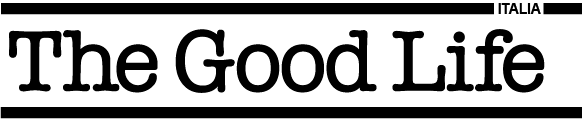Art for Tomorrow: la creatività in lotta per un mondo migliore
“L’umano è un macro organismo batterico, un contenitore di batteri. L’architettura anti batterica è un’architettura anti umana”. Hanno spiegato così Beatriz Colomina e Mark Wigley la loro partecipazione alle 24esima Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, dal titolo Inequalities. Queste parole sono apparse in un’intervista su La Lettura del Corriere della Sera rispettivamente alla fondatrice e direttrice del programma Interdiciplinary Media and Modernity alla Princeton University e allo storico dell’architettura e preside emerito della Columbia University. Uno sguardo radicale, che ha a che fare con un necessario ripensamento della presenza umana sulla Terra e che in questa occasione si concentra sul concetto di disuguaglianza e di disparità in favore di un’architettura che «ci riconnetta al suolo, alle piante, alle altre specie viventi». Non è che una proposta tra quelle che andranno a comporre l’esposizione, ultimo atto di una trilogia che è iniziata nel 2019 con Broken Nature, incentrata sul nostro rapporto con la natura, per poi procedere con Unknown Unknowns, per indagare l’ignoto ancora così ampio in ambito scientifico e approdare a Inequalities, in scena da maggio a novembre per ragionare sulle diseguaglianze. Quelle che principalmente animano le città: «Le città del mondo, che oggi occupano solo un 3% della superficie delle terre emerse del Pianeta, producono da sole il 75% dell’anidride carbonica che accumulandosi nell’atmosfera genera il surriscaldamento globale e i suoi effetti sul clima».

unequal scenes per inequalities: la presa aerea delle diseguaglianze urbane in questi scatto di un lembo di città argentina di johnny miller.
Ed è proprio nei contesti urbani il luogo in cui verrà vinta o persa la sfida dei prossimi decenni, sia per quanto riguarda la riduzione del surriscaldamento globale, sia per il superamento delle diseguaglianze sociali, a fronte di una previsione per il 2050 di oltre 250 mln di profughi e rifugiati climatici, in fuga dalla desertificazione. Lo ha spiegato Stefano Boeri, presidente di Triennale che ha fortemente voluto questo progetto, dando vita a una serie di appuntamenti preliminari, in preparazione della grande esposizione. Nel settembre scorso si è tenuto un forum sul tema che ha raccolto diversi studiosi per comporre una voce collettiva della disuguaglianza. In quell’occasione il tema veniva analizzato su scale diverse, dalla dimensione globale della geopolitica e delle migrazioni a quella più locale delle disparità nella distribuzione delle risorse nelle singole città, fino all’infinitamente piccolo dei batteri. Gli esperti coinvolti in questa prima performance appartengono a realtà come, per esempio, Theatrum Mundi (theatrum-mundi.org) un’organizzazione che riunisce giovani artisti e urbanisti e il New York Institute for the Humanities (che vanta tra i soci fondatori, sin dal 1977, nomi da capogiro come Susan Sontag, Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Czesław Miłosz e Philip Glass, Michel Foucault e Roland Barthes). Fondatore è Richard Sennett, sociologo, critico letterario e scrittore statunitense (nonché membro del Council on Urban Initiatives delle Nazioni Unite) che presiede anche il consiglio dei fiduciari di Theatrum Mundi, con l’obiettivo di mettere individui e comunità in grado di partecipare ai processi di sviluppo urbano attraverso metodi creativi, sostenendoli nella realizzazione di lavori innovativi e sperimentali. La direzione è quella interdisciplinare, dove l’arte ha una funzione molto importante. Non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista sociale: una forma di attivismo che coinvolge artisti e cittadini. Art For Tomorrow (artfortomorrow.org) parteciperà a Inequalities con un convegno di due giorni (12-14 maggio) in cui personalità del mondo dell’arte, del design e dell’architettura esploreranno l’impatto che questi campi possono avere sulla società, considerando gli eventi che stanno sconvolgendo il mondo, tra guerre e disuguaglianze, esacerbate dalle crisi politiche, economiche e climatiche. Art For Tomorrow è un consolidato appuntamento nato in seno alla Democracy and Culture Foundation (democracyculturefoundation.org) fondata nel 2019 per aiutare la democrazia a evolversi, sostenendo la società attraverso l’impegno dei cittadini in vista di una migliore governance.

tra i relatori di art for tomorrow 2025, il pittore venezuelano alvaro barrington e khalid albaih political cartoonist, dal sudan. un talk della tappa del 2022 di atene.
Ma perché l’arte è un dispositivo del cambiamento sociale? «Ormai milioni di persone hanno visto video e post di manifestanti in maglietta bianca con la scritta Just Stop Oil che gettavano zuppe sui Girasoli di Van Gogh o si incollavano – letteralmente – alla Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer», spiega il presidente di Democracy and Culture Foundation, Achilles Tsaltas. «Quello è un modo di sfruttare le arti e la cultura per protestare e far luce sulle cause che si vogliono sostenere. Un altro modo più diretto è quello in cui gli artisti si esprimono in modo da posizionare l’arte che producono come una protesta e una richiesta di cambiamento sociale. Alla conferenza Art for Tomorrow (organizzata con il New York Times, in collaborazione con la Moleskine Foundation), valutiamo come conciliare il bisogno dei manifestanti di attirare l’attenzione sulla loro causa con il meccanismo di dissenso che hanno scelto. Inoltre, analizziamo l’efficacia delle varie forme di contestazione nel risolvere realmente i problemi. Portiamo avanti il concetto di arte come forma di attivismo anche con un premio, il Creativity for Social Change Award, ideato per riconoscere i talenti artistici e creativi che producono opere che suscitano cambiamenti sociali». Che l’arte possa essere il linguaggio della protesta non è certo una novità, a partire dal celeberrimo Guernica di Pablo Picasso. Ma qui si parla soprattutto di impatto sociale e comunità da coinvolgere. «In quest’epoca di divario sociale, dove è sempre più complicato e difficile capire l’altro, consideriamo le Community Based Arts (arti incentrate sulla comunità) per esaminare come un numero crescente di architetti, artisti e istituzioni si stiano inserendo profondamente nelle comunità con il loro lavoro, progettato per colmare le disuguaglianze». Le guerre e la situazione geopolitica attuale influenzano il vostro lavoro? – chiedo a Tsaltas. «Con i conflitti che imperversano da Gaza all’Ucraina, dal Sudan alla Siria, si potrebbe pensare che la produzione artistica sia soffocata poiché è in discussione la sopravvivenza quotidiana. Ma spesso è vero il contrario: la creatività resiste e addirittura fiorisce. Le guerre e gli spostamenti geopolitici influenzano il nostro lavoro che si sofferma a esaminare il modo in cui l’arte può aiutare le persone ad affrontare i tempi bui e come può aiutare gli altri a comprendere sia l’orrore sia la resistenza nella guerra. Alla conferenza milanese ne parleremo espressamente».

littlegig, fondata da georgia black, è definita una «comunità temporanea e diversificata che diventa una piattaforma globale per l’economia creativa africana».


L’instabilità attuale non è solo relativa alle guerre purtroppo in corso. Se l’Europa sarà dominata dalle destre politiche, dovrete cambiare le vostre strategie? «Le nostre conferenze non sono politiche: siamo una piattaforma indipendente che permette la libertà di espressione e di pensiero. Invitiamo tutti a esprimere il proprio punto di vista, moderati e a volte contestati dai nostri giornalisti, e il pubblico trae le proprie impressioni e opinioni da ciò che ascolta. Naturalmente, siamo liberali e crediamo nella diversità e nell’inclusione, per questo motivo la nostra missione è quella di incoraggiare azioni che abbiano un impatto sociale e portino soluzioni ai numerosi problemi che il nostro mondo sta vivendo». Spostando lo sguardo verso sud, occorre guardare l’Africa, terra promessa dell’arte e dell’artigianato del prossimo futuro, già esplorata da galleristi e istituzioni museali per la ricchissima produzione artistica contemporanea. Ma ancora troppo distante, ancora troppo “diseguale”. Ad accendere i riflettori su quei territori è Georgia Black, fondatrice di Littlegig, «una comunità temporanea e diversificata che diventa una piattaforma globale per l’economia creativa africana», come l’ha definito lei stessa. Che significa? Microfestival di tre giorni per 100 invitati al massimo che si incontrano ed esplorano luoghi, musiche e storie. L’ultima apparizione in ordine di tempo è stata a Homo Faber a Venezia, dove ha convogliato circa 80 persone tra designer, artisti, albergatori, architetti, produttori musicali, attori in uno degli appuntamenti più iconici della scorsa stagione. Ma sta già lavorando al prossimo festival. «Non c’è ancora nulla di definito, ma sarà nel 2026 sulla costa dell’Africa orientale, un luogo che, dal punto di vista energetico e artistico, è un sogno», commenta Black. «A ispirarmi sul fronte musicale sono gli artisti africani e diasporici Baloji (Belgio/Rdc) e Muzi (Sudafrica), ma anche Aṣa (Nigeria) e Cleo Sol, ma non mancheranno registi, chef e scrittori». A cosa serve questo festival? A dimostrare che il pubblico è l’arte.